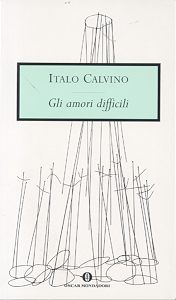“Alla stazione Termini, il primo a saltar giù dal vagone, fresco come una rosa, era lui. In mano stringeva il gettone. Nelle nicchie tra i pilastri e gli stand, i telefoni grigi non attendevano che lui. Infilò il gettone, fece il numero, ascoltò col batticuore il trillo lontano, udì il – Pronto…- di Cinzia emergere ancora odoroso di sonno e di soffice tepore, e lui era già nella tensione dei loro giorni insieme, nell’affannosa guerra delle ore, e capiva che non sarebbe riuscito a dirle nulla di quel che era stata per lui quella notte, che già sentiva svanire, come ogni perfetta notte d’amore, al dirompere crudele dei giorni.”
(Gli amori difficili, p. 73)
Di Italo Calvino non si può certo dire che non sia stato uno scrittore prolifico: la sua biografia è scandita dalla pubblicazione di romanzi, novelle, sperimentazioni letterarie, saggi, articoli che, in un modo o nell’altro, hanno condizionato (e continuano ancora ad influenzare) la letteratura italiana moderna e contemporanea, sia per quanto concerne il dibattito estetico che quello puramente utilitario (su quale, cioè, debba essere il ruolo della letteratura nella vita degli uomini).
In ogni caso, Gli amori difficili, il libro che vorrei proporvi, rappresenta soltanto un piccolo granello di sabbia nel vasto orizzonte delle sue opere; tuttavia, ritengo che sia un ottimo punto di partenza, un piccolo capolavoro narrativo, nel quale confluiscono tutte le caratteristiche espressive e formali dell’autore.
Il libro si configura come una breve raccolta di novelle, ciascuna incentrata su un protagonista (due al massimo) intento ad affrontare la propria routine in rapporto all’Altro.
E’ come se l’autore si addentrasse nel groviglio delle esistenze individuali con una lente e ne raccontasse un piccolo episodio, apparentemente banale ed estremamente abitudinario, illuminandolo e caricandolo di una misteriosa spontaneità, elevandolo ad episodio Letterario ma reale e terribilmente quotidiano.
Tracciando qualche breve pennellata descrittiva, con uno stile leggero, vivace, vivo, palpitante, Calvino introduce il lettore nella vita di un uomo, o di una donna, e poi lascia che la narrazione stessa si impossessi del lettore e ne amplifichi i suoi stessi timori e le sue felicità; egli penetra nei meandri delle nostre profondità attraverso un particolare banale o un episodio casuale, racconta i gesti e non i pensieri, permette all’azione di dominare sulla parola, alla descrizione di dominare sulla poesia, al dialogo di dominare sul monologo interiore.
Tuttavia, nel libro non si avverte il peso di nessuna mancanza; il vuoto del simbolo viene colmato dal reale stesso, come se venisse caricato di una misteriosa forza metafisica onnipresente, che sottende alle vicende, alle cose, alle persone; un gesto diviene il gesto, una parola diviene la parola e sembra che non possa essere altrimenti, in quanto essa stessa accade in quel momento, nel presente del suo svolgersi.
Questa sorta di racconto inevitabile dei rapporti umani porta con sé una sottile e pervasiva malinconia, un sentimento di serena tristezza nascosta tra le pieghe del reale; i personaggi si amano, si vogliono bene, si incontrano, vivono senza accorgersi della lente che li indaga e li racconta, e proprio in tale inconsapevolezza sentiamo di esser loro vicini, sentiamo che in un particolare momento della nostra vita avremmo agito come loro, avremmo pensato i loro pensieri e patito le loro (le nostre) tristezze.
Da qui, avvertiamo una sorta di sovrapposizione della parola sull’azione, della poesia sulla descrizione, del pensiero sul dialogo. Non solo: il particolare tanto amato dallo scrittore diviene universale umano, l’infinitamente piccolo si capovolge nell’infinitamente grande e, infine, la misera storiella umana si rivela essere l’unica grande Storia della vita. A Calvino va, dunque, il merito dell’emancipazione del quotidiano.
A noi va, nonostante tutto, il merito inconsapevole della malinconica tenerezza del nostro agire.
Italo Calvino, Gli amori difficili, Mondadori, 1993, pp. 264, € 9,50.